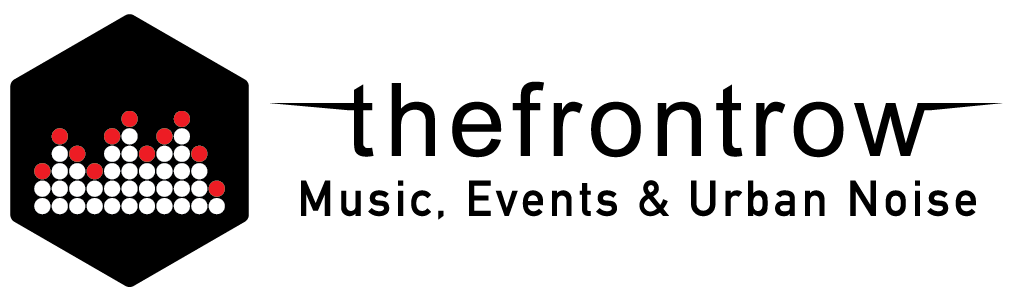Che Raphael Gualazzi e la musica siano una sola cosa, te ne accorgi quando chiacchieri con lui. Gli si illuminano gli occhi, quasi dirti che un bene più prezioso non esiste. Ma te ne accorgi anche quando entri nel suo camerino, dove, insieme alle sue inseparabili tisane, troneggia una tastiera, indispensabile per il training prima di salire sul palco. Ma te ne rendi conto soprattutto quando siede al pianoforte, davanti a centinaia di persone che lo guardano con adorazione. In quel momento per lui ci sono i 52 tasti bianchi e i 36 neri. C’è una band che lo asseconda e ci sono le sette note. Nessuno spazio per gli eccessi, per le trovate sceniche. In due ore di spettacolo saranno forse un centinaio le parole che spende, in buona parte per raccontare il brano che sta per interpretare e per presentare i suoi compagni sul palco. Avevamo un certo timore, quando ci hanno detto che l’intervista era fissata per le 20, perché Raphael poi si sarebbe dovuto concentrare. Figuratevi, quando abbiamo saputo che a causa di un ritardo organizzativo (l’artista aveva recuperato all’ora di pranzo il concerto di Bologna, rinviato a causa delle pioggia) il nostro slot temporale è stato spostato alle 21, a meno di mezz’ora dalla salita sul palco. E’ bastato poco per creare il feeling: gli abbiamo chiesto, parlaci della tua musica. Gli occhi si sono illuminati e si è aperto alle nostre domante.
Ecco cosa ci ha raccontato.
Raphael, tu provieni da una famiglia di musicisti. Era inevitabile che tu facessi questo mestiere. Ma cosa ti ha spinto a diventare quello che sei oggi: un cantautore jazzista?
«Io ho fatto studi classici, entrando al Conservatorio all’età di 14 anni. Sin da bambino ascoltavo tantissima musica. Ho sempre tenuto la mia mente aperta a tutti i generi, pescando dalla ricchissima collezione di vinili di mio padre. Il conservatorio, almeno a quei tempi, non aveva un corso di pianoforte jazz e nemmeno di improvvisazione, per cui tutto ciò che si imparava in questo campo era frutto della ricerca personale. Così dopo le lezioni era cosa consueta che mi incontrassi con i colleghi di studio e con loro studiassimo gli standard. Ci concentravamo soprattutto sul bebop, l’hardbop e il jazz modale. Un giorno, in occasione di Urbino Jazz ebbi la fortuna di incontrare un chitarrista, Jimmy Villotti, uno strumentista sicuramente noto anche dalle vostre parti, visto che ha accompagnato Paolo Conte. Dopo il suo concerto, lo incontrai per fargli i complimenti, e lui mi diede qualche dritta su come affrontare la musica».
Che cosa ti disse?
«Mi disse che un appassionato di jazz come me, avrebbe dovuto iniziare a studiare gli standard più semplici, come il blues e il ragtime. Mi consiglio di ritornare agli anni ’20 quando nacque il genere, come si sviluppò. Da quel momento tutto è cambiato. Mi sono concentrato su questi ascolti e ho iniziato a suonare come ospite in gruppi locali che coltivavano questo tipo di repertorio».
Poi hai iniziato a diventare autore…
«Esatto. Ho iniziato a scrivere brani che volevano fondere ciò che avevo imparato al Conservatorio, con la crescente passione per il blues e il jazz. Nel 2005 mentre usciva il mio primo album Love Outside the Window, hi iniziato ad occuparmi dello stride piano e dei suoi magnifici interpreti: Art Tatum, Fats Waller e James P. Johnson. Un mondo meraviglioso che ha portato il bagaglio europeo dentro il vibe afro-americano, diventando un punto di riferimento musicale fantastico».
Passa qualche anno e arriva una certa Cterina Caselli, che ti invita a sdoganare il Jazz al Festival di Sanremo, portando un brano, Follia d’Amore, certamente lontano dai canoni rivieraschi. Non hai avuto paura di un simile esperimento?
«Diciamo che il Festival è una grande opportunità di portare al grande pubblico un genere sicuramente di nicchia. Sebbene fossi emozionato, ho potuto parlare della musica di cui mi ero innamorato. Fino a quel momento avevo condiviso le mie esperienze con amici e colleghi… ma poterlo fare davanti a milioni di persone… Sanremo è un evento mediatico particolare. Basta varcare il confine con la Francia per raccogliere tutto lo stupore degli addetti ai lavori, che si chiedono come sia possibile che oltre 13 milioni di persone possano rimanere davanti alla televisione per un concorso musicale. E’ stata un’esperienza positiva, al di là del risultato, visto che a me non interessava l’aspetto competitivo. Sicuramente ho visto accrescere il mio bagaglio professionale».
Poi lo stesso brano, seppure tradotto in inglese, l’hai portato all’Eurovision Song Contest…
«Un’esposizione pazzesca. In quell’edizione ci furono 110 milioni di spettatori per la finale, oltre ai 37 mila che erano nella sala. Fu estremamente difficile, ma allo stesso tempo meraviglioso. Per due settimane ho avuto la possibilità di parlare di musica e della storia che mi aveva ispirato. In fondo il jazz ed il blues sono alla base della produzione musicale moderna ed io sono stato contento, nel mio piccolo, di aver svolto quest’opera di divulgazione».
Hai detto che sei sempre aperto a tutti i generi musicali, comprese le contaminazioni elettroniche che hai proposto facendoti accompagnare da Bloody Beethrot. Pensi che possa essere questa la strada per portare Raphael Gualazzi ad una dimensione veramente mainstrem, in grado di passare con costanza in radio?
«E’ vero ho fatto tante esperienze musicali e altrettanti esperimenti. Per ciò che mi riguarda non so se ci sia una vera formula verso la mediaticità. Non ce la faccio a suonare un brano, se non ne sono convinto al 100%, ma soprattutto non riuscirò a fare un album che contiene brani simili, mi annoierebbe farlo, ma mi annoierebbe anche ascoltarlo. Probabilmente non avrò un grande futuro nel mainstream o forse sì. L’unica cosa in cui credo è il mio lavoro. Magari succederà come nel 2010, quando Gilles Patterson prese il mio brano Reality and Fantasy, ne fece un remix e conquistò il mercato discografico francese. Forse mi serve un colpo di fortuna. Io proseguirò a sperimentare con l’elettronica, con la musica sinfonica, con il jazz, il rock, il funk. Per trovare il mio contenitore dovrò continuare a suonare»
Non ti senti un po’ sfregiato da questo tentativo commerciale?
«No, perché Patterson non ha fatto altro che aggiungere un qualcosa di suo, in un brano che è diventato un qualcosa di diverso. Questo era quello che lui vedeva e non c’è niente di male se lo ha proposto. In fondo la musica è di tutti, è universale e ci dovrebbe essere la possibilità di creare una propria estetica, una versione originale. L’importante è essere mossi dal desiderio di fare qualcosa di bello».
Sono oltre due anni che non pubblichi album. C’è qualcosa in cantiere?
«Il prossimo album dovrebbe uscire nei primi mesi del 2016. Sarà un disco di inediti. In realtà avevamo portato avanti un altro progetto, che proponeva il riarrangiamento di brani editi, ma poi abbiamo deciso di accantonarlo per un attimo, perché non ritenevamo fosse il momento propizio. Così ci siamo concentrati sul nuovo materiale».
Tu sei un appassionato di tisane, ma questa sera ti trovi nel paese del Barolo. Lo assaggerai?
«Sicuramente non prima di suonare, perché cerco di evitare bevande alcoliche. A cena sarò felice di assaggiarlo, magari in compagnia dei musicisti francesi che mi accompagnano. Loro sono appassionati e potranno vedere quanto di bene gli italiani sono capaci di fare».
A cura di Vincenzo Nicolello. Si ringrazia la Sugar Music per la disponibilità.